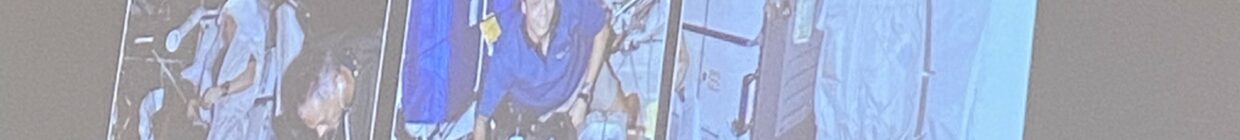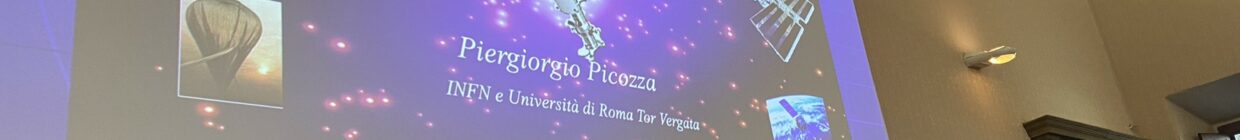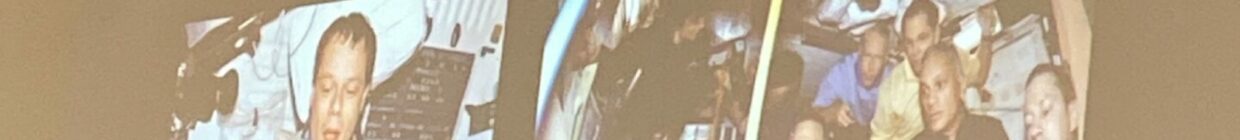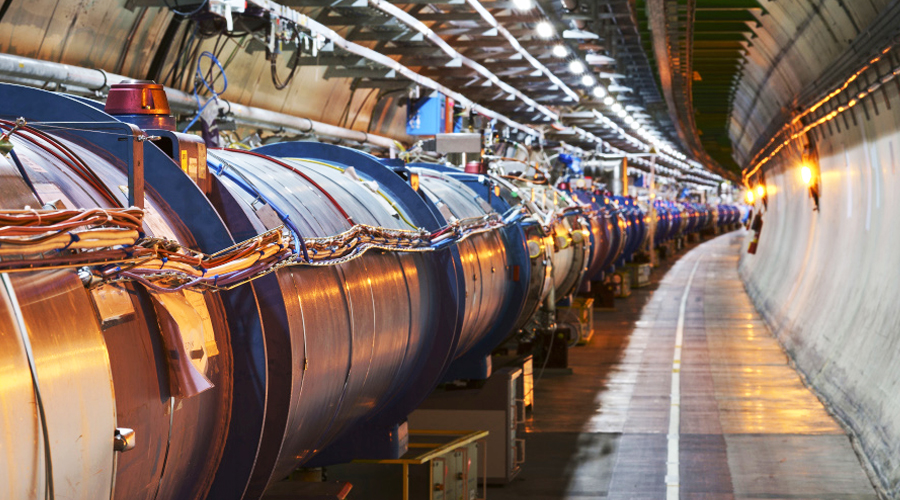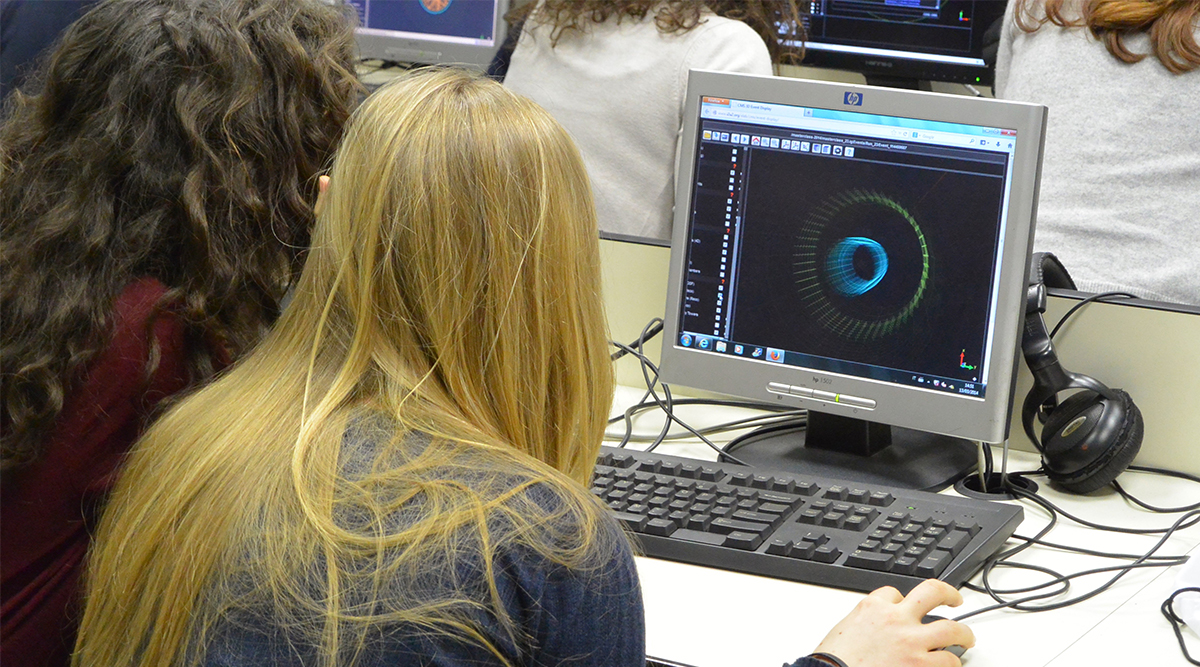Uno nuovo studio condotto dalle ricercatrici e dai ricercatori della collaborazione europea MAGIC ha reso nota l’osservazione di un flusso di raggi gamma ad alta energia proveniente da una nova ricorrente nella Via Lattea. L’evento, il primo del suo genere a essere stato rivelato a simili energie, fa luce su una classe di fenomeni astrofisici considerati responsabili delle periodiche esplosioni che hanno luogo sulla superficie delle novae – corpi stellari appartenenti alla famiglia delle nane bianche – e dell’emissione di una parte dei fotoni che costituiscono il fondo di radiazione gamma che permea la nostra intera galassia. Il risultato, presentato in un articolo pubblicato oggi, 14 aprile, sulla rivista Nature Astronomy, è stato ottenuto grazie alle rivelazioni effettuate dai due telescopi Cherenkov situati nell’isola di La Palma (Isole Canarie), in Spagna, di cui si compone il sistema MAGIC, che vede l’Italia impegnata con un ruolo di primo piano attraverso i contributi dell’istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN).
Prima di essere ‘fotografato’ da MAGIC l’8 agosto 2021, l’evento descritto nell’articolo di Nature Astronomy è stato individuato dal rivelatore Large Area Telescope a bordo dell’osservatorio spaziale Fermi della NASA e dai telescopi dell’High Energy Stereoscopic System (HESS) in Namibia. A seguito degli avvisi tempestivi lanciati dalle due collaborazioni, è stato possibile orientare i sensibili telescopi gemelli di MAGIC nella direzione di arrivo del flusso di raggi gamma, la cui origine è stata attribuita all’attività del sistema RS Ophiuchi, situato nella costellazione dell’Ofiuco (portatore di serpenti) a 8000 anni luce di distanza dalla Terra, una sorgente galattica ricorrente, la cui ultima esplosione era stata registrata nel 2006.
“Grazie alle buone condizioni di osservazione presenti a La Palma, alla rapida reazione della collaborazione e alla sensibilità unica offerta dal sistema MAGIC”, spiega Ruben Lopez-Coto, ricercatore del progetto ‘Fellini’ della Sezione INFN di Padova e uno dei principali autori dello studio, “siamo riusciti a individuare in tempo l’eruzione di RS Ophiuchi, un evento raro nel cielo dei raggi gamma, poiché rappresenta la luce prodotta da nova più luminosa e con il flusso più elevato di raggi gamma, e quindi più lontana, mai rivelata.”
In concomitanza con le rivelazioni di MAGIC, l’evento RS Ophiuchi 2001 è stato inoltre oggetto delle osservazioni di strumenti operanti in differenti lunghezze d’onda, come il Joan Oró Telescope (TJO) dell’osservatorio Montsec (Spagna), lo spettrografo Echelle del telescopio di Varese e lo spettropolarimetro CAOS della stazione osservativa di Serra La Nave dell’INAF di Catania, diventando il primo del suo genere a essere studiato sia dalla Terra che dallo spazio in un così ampio spettro di energia.
L’analisi di RS Ophiuchi 2021 condotta da parte della collaborazione MAGIC, che si è potuta avvantaggiare di dati raccolti in tutte le lunghezze d’onda, ha perciò consentito di identificare le novae come un nuovo tipo di sorgenti di raggi gamma, aprendo una nuova linea di ricerca nell’astronomia ad altissima energia e confermando uno dei modelli astrofisici proposti per spiegare la presenza dei raggi cosmici altamente energetici che permeano la Via Lattea. L’esplosione della nova è stata infatti abbastanza energetica da produrre forti onde d’urto nel tenue mezzo che circonda il sistema stellare. Uno shock che è considerato tra i meccanismi fisici responsabili dell’accelerazione, a velocità prossime a quelle della luce, delle particelle subatomiche di cui si compongono i raggi cosmici.
“Nel caso della spettacolare eruzione di RS Ophiuchi 2021, il modello che meglio descrive le osservazioni di MAGIC e di altri telescopi fa risalire l’origine dei raggi gamma ad altissima energia rivelati all’accelerazione dei protoni, particelle cariche positivamente che compongono i nuclei degli atomi di idrogeno”, illustra Mosè Mariotti, docente dell’Università di Padova e ricercatore INFN, già portavoce della collaborazione MAGIC.
“Sebbene le eruzioni in una nova siano individualmente meno energetiche delle loro parenti molto più violente – le supernovae, dove una stella di grande massa muore in un’esplosione catastrofica -, sono però molto più frequenti, e forniscono una spiegazione alla sovradensità di raggi gamma osservati nelle loro vicinanze. Il risultato mostra quindi che le novae brillano nei raggi gamma di altissima energia originati dall’accelerazione dei protoni, aprendo una nuova finestra sulla conoscenza di questa tipologia di raggi cosmici”, prosegue Antonio Stamerra, ricercatore dell’INAF di Roma e coordinatore della scienza di MAGIC.
Nell’ambito della classificazione stellare, che suddivide i tipi di stelle sulla base delle loro fasi evolutive, a loro volta determinate dalla massa stellare, le novae rientrano all’interno della categoria appartenente alle cosiddette nane bianche, termine che identifica stelle con masse simili a quella del nostro Sole giunte al termine della loro vita.
“La formazione di tali corpi celesti, è dovuta al collasso che si verifica come conseguenza dell’esaurimento di tutto il combustibile capace di alimentare le reazioni di fusione nucleare che avvengono nel nucleo della stella. Un destino analogo a quello a cui andrà incontro tra cinque miliardi di anni il Sole, il quale si trasformerà in un oggetto composto da materiale molto denso in grado di irradiare esclusivamente calore residuo”, spiega Lucio Angelo Antonelli, ricercatore dell’INAF di Roma e responsabile nazionale INAF presso la collaborazione MAGIC.
Nonostante siano oggetti inerti, le nane bianche possono essere responsabili, in particolari circostanze, di violente esplosioni. Ciò avviane quando, in presenza di una vicina stella nella sua fase di Gigante Rossa, l’idrogeno prodotto da quest’ultima viene catturato dal campo gravitazionale della nana bianca, andandosi ad accumulare sulla sua superficie. Il trasferimento di materiale da una stella ancora attiva a una ormai morta, una sorta di ‘vampirismo stellare’, può infine provocare, una volta raggiunte temperature e pressioni tali da innescare le reazioni di fusione nucleare, esplosioni ricorrenti sulla superficie della nova.
“Durante la fase esplosiva il materiale espulso dalla superficie della nana bianca sfugge a una velocità tremenda, da duemila a quattromila chilometri al secondo. In alcuni sistemi il ciclo di trasferimento del gas dalla stella gigante alla nana densa può ricominciare e questo provoca una ricorrenza del fenomeno di eruzione della nova. Questi sistemi vengono chiamati novae ricorrenti”, chiarisce Francesco Leone, docente dell’Università di Catania ed INAF di Catania.
Nonostante l’emissione di raggi gamma da RS Ophiuchi abbia fornito la prima prova convincente dell’accelerazione dei protoni nelle novae, non è ancora chiara quale sia la natura del corpo stellare oggetto della ‘vampirizzazione’.
“Ancora non sappiamo se l’evento osservato sia correlato alla particolarità di avere una stella Gigante Rossa come stella compagna della nana bianca, o piuttosto a una proprietà più generale di tutte le novae. Ulteriori osservazioni di novae con i telescopi Cherenkov ci permetteranno di rispondere a questa domanda”, conclude Riccardo Paoletti, docente dell’Università di Siena e responsabile nazionale della collaborazione MAGIC per l’INFN.
Per maggiori informazioni: ‘Proton acceleration in thermonuclear nova explosions revealed by gamma rays’