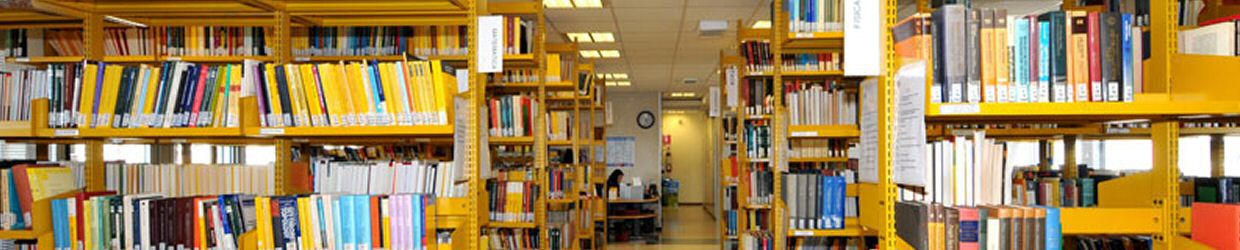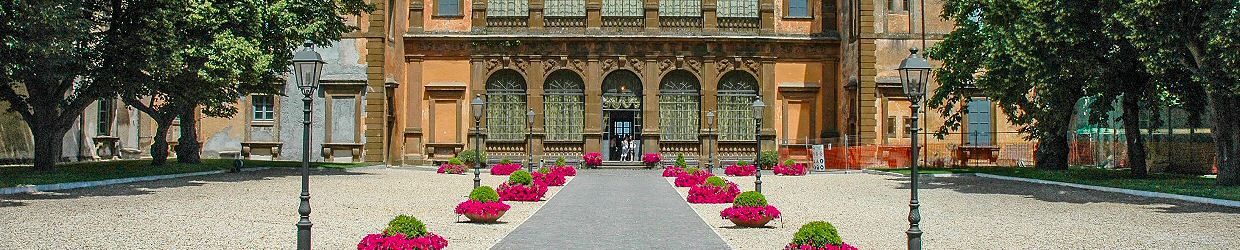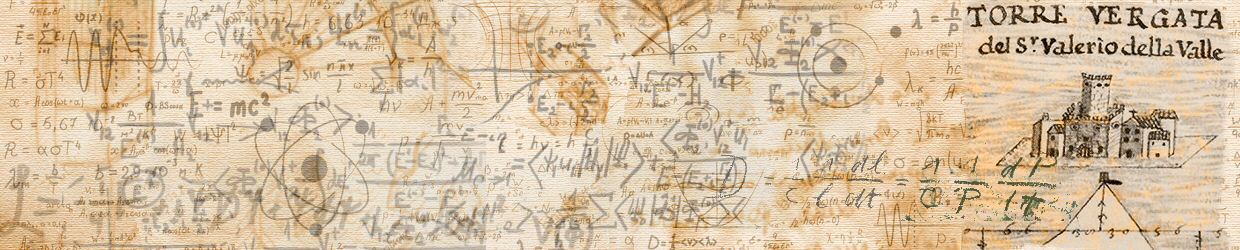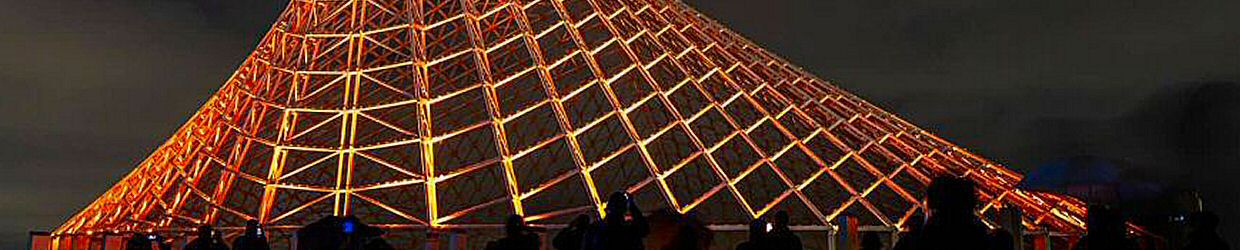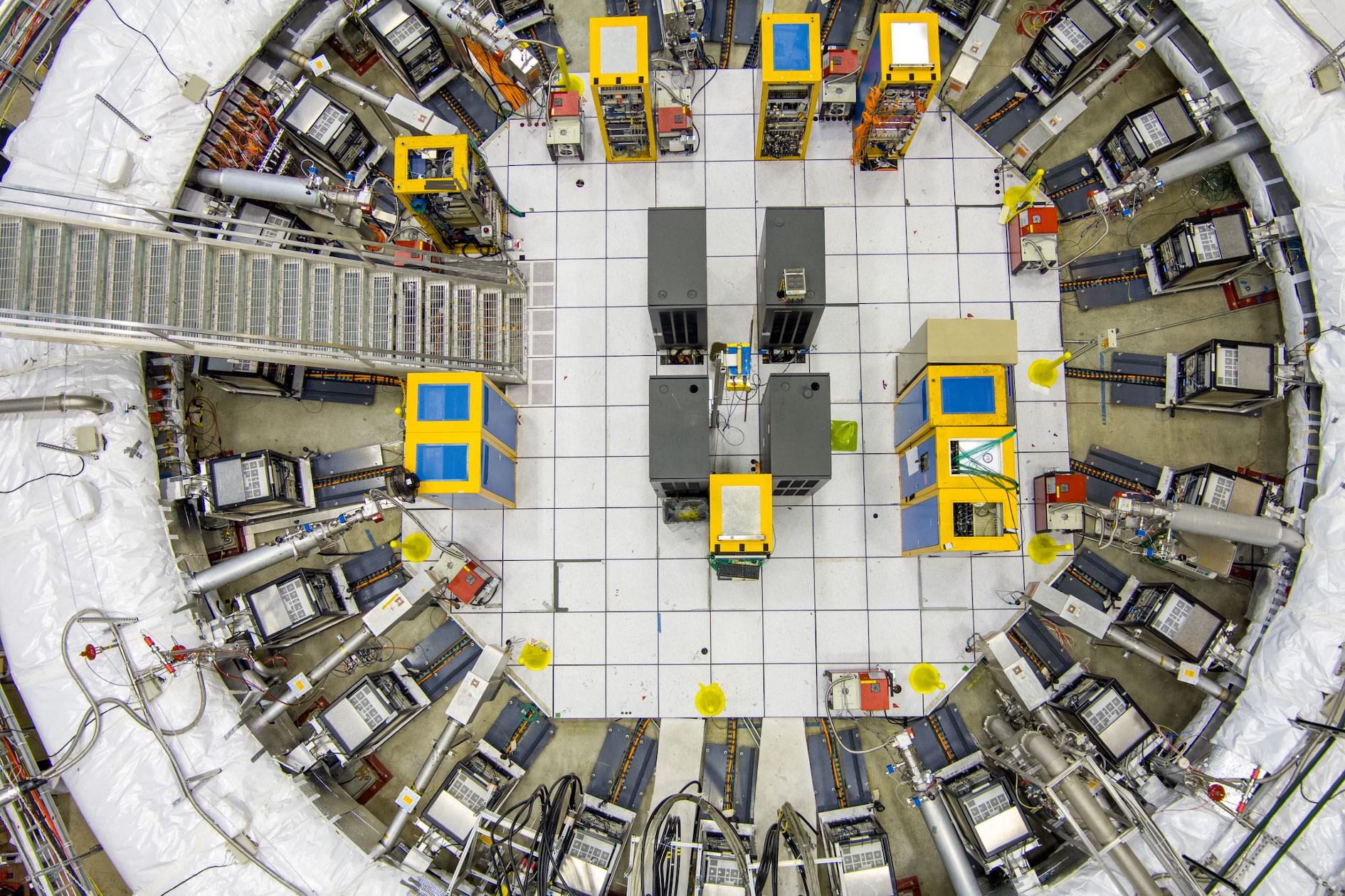Sono arrivate sulla Terra le prime immagini del telescopio spaziale europeo Euclid. Talmente incredibili per la loro nitidezza che alcuni scienziati le hanno definite “immagini ipnotizzanti”. A riprenderle sono stati i due strumenti, con forte contributo italiano, appena accesi: VIS (VISible Instrument) e NISP (Near Infrared Spectrometer Photometer) che sono ancora in fase di calibrazione. Alla loro realizzazione hanno giocato un ruolo importante a livello continentale, l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)
Anche se mancano un paio di mesi prima che Euclid cominci a fornire la sua vera nuova visione del cosmo, il raggiungimento di questo traguardo mostra che gli scienziati e gli ingegneri sono fiduciosi che il telescopio ed i suoi strumenti funzionino bene. Gli ottimi risultati fin qui ottenuti, indicano che il telescopio spaziale raggiungerà gli obiettivi scientifici per cui è stato progettato, e forse molto di più.
“Dopo più di 11 anni di progettazione e sviluppo di Euclid, è esaltante ed estremamente emozionante vedere queste prime immagini”, afferma Giuseppe Racca, project manager di Euclid per l’Agenzia Spaziale Europea (ESA). “È ancora più incredibile se pensiamo di vedere solo poche galassie qui, prodotte con una messa a punto minima del sistema. Euclid, una volta calibrato completamente, osserverà miliardi di galassie per creare la più grande mappa 3D del cielo mai vista prima”.
“Le immagini degli strumenti VIS e NISP diffuse oggi dimostrano la bontà della catena di acquisizione della luce raccolta nel campo di vista del telescopio di Euclid. – riferisce Mario Salatti, responsabile per ASI della realizzazione del contributo italiano agli strumenti scientifici a bordo del satellite Euclid – Il team industriale coinvolto nella costruzione del cuore delle unità elettroniche dei due strumenti VIS e NISP e il team scientifico che ne ha sviluppato il software guardano con grande soddisfazione alla qualità di queste immagini da cui viene confermato il raggiungimento delle specifiche di progetto”.
Lo strumento VISible di Euclid (VIS) scatterà immagini super nitide di miliardi di galassie per misurarne le forme. Già dalla prima immagine si intravede la capacità che avrà il VIS; mentre alcune galassie sono molto facili da individuare, molte altre sono macchie sfocate nascoste tra le stelle, in attesa di essere svelate da Euclid in futuro. Sebbene l’immagine sia ricca di dettagli, l’area di cielo che copre è in realtà solo circa un quarto della larghezza e dell’altezza della Luna piena.
“Accendere uno strumento spaziale è un’esperienza unica: quando tutto era pronto, abbiamo inviato al satellite il comando di power-on e letteralmente abbiamo smesso di respirare fino a che, qualche secondo dopo, non abbiamo visto i primi dati di telemetria scorrere sullo schermo, riportando lo stato dello strumento in funzione. L’emozione è stata tanta e tra applausi e abbracci, ci siamo rimessi subito tutti al lavoro, consapevoli che questo è solo l’inizio dell’avventura” racconta Anna Di Giorgio dell’INAF, che coordina le attività italiane per la missione Euclid finanziate dall’ASI e ha partecipato, insieme ad altri ricercatori INAF e INFN, al collaudo dei due strumenti presso il centro di controllo dell’ESA. “Altro momento critico è stato quello dell’accensione dei rivelatori e l’acquisizione dei primi dati, seguito dalla meraviglia di poter finalmente vedere delle immagini vere e non simulate. Certo ci sono stati degli imprevisti (senza i quali che avventura sarebbe?), come la scoperta di un fondo inaspettato di luce diffusa, che alla fine hanno dato all’intera squadra l’opportunità di lavorare se possibile in modo ancora più coeso e motivato. Anche in questi casi la professionalità del personale italiano, sia i ricercatori che il team industriale, ha contribuito in modo decisivo a tenere la situazione sotto controllo e a definire possibili strategie risolutive.”
Lo strumento NISP (Near-Infrared Spectrometer and Photometer) di Euclid ha un duplice ruolo: fotografare le galassie nella luce infrarossa e misurare la quantità di luce che le galassie emettono a varie lunghezze d’onda. Questo secondo ruolo ci permette di capire direttamente quanto è lontana ogni galassia.
“Euclid rappresenta la prima missione del suo tipo a cui l’INFN contribuisce, e siamo molto soddisfatti per questo iniziale importante passo, reso possibile anche grazie al ruolo svolto dall’INFN, e che dimostra la capacità di Euclid di realizzare quanto si è prefisso: una mappa estesa dell’Universo, che sarà in grado di fornire decisive misure anche in quei settori in cui l’INFN è maggiormente coinvolto, come la fisica dei neutrini, andando a complementare le ricerche in questo ambito svolte in laboratorio”, aggiunge Luca Stanco, ricercatore INFN della sezione di Padova e responsabile della missione Euclid per l’INFN.
Combinando le informazioni sulla distanza con quelle sulle forme delle galassie misurate dal VIS, saremo in grado di mappare come le galassie sono distribuite nell’Universo e come questa distribuzione cambia nel tempo. In definitiva, questa mappa 3D ci porterà a comprendere meglio la materia oscura (che interagisce gravitazionalmente con la materia ordinaria) e l’energia oscura (che causa l’attuale accelerazione dell’espansione dell’Universo).
In Euclid sono coinvolti oltre duecento scienziate e scienziati italiani, appartenenti all’ASI, all’INAF, all’INFN e a numerose università, in primo luogo l’Università di Bologna e poi Università di Ferrara, Università di Genova, Università Statale di Milano, Università di Roma Tre, Università di Trieste, SISSA e CISAS.
Nei prossimi mesi, l’ESA continuerà a svolgere tutti i test e i controlli necessari per garantire che Euclid funzioni nel miglior modo possibile. Al termine di questa “fase di messa in servizio”, inizierà la vera scienza. A quel punto l’ESA rilascerà una nuova serie di immagini che mostreranno le straordinarie capacità della missione.