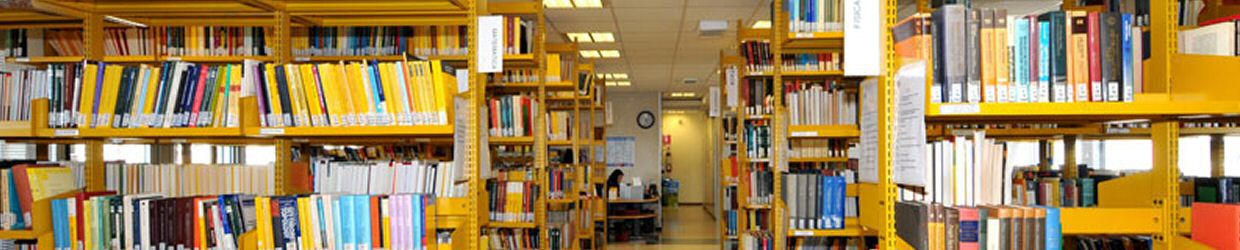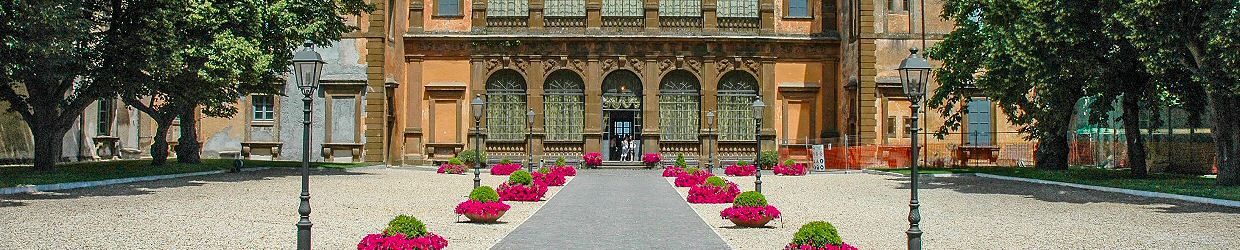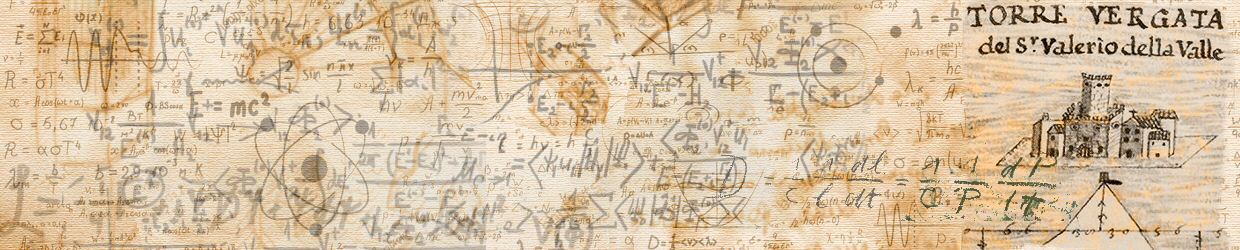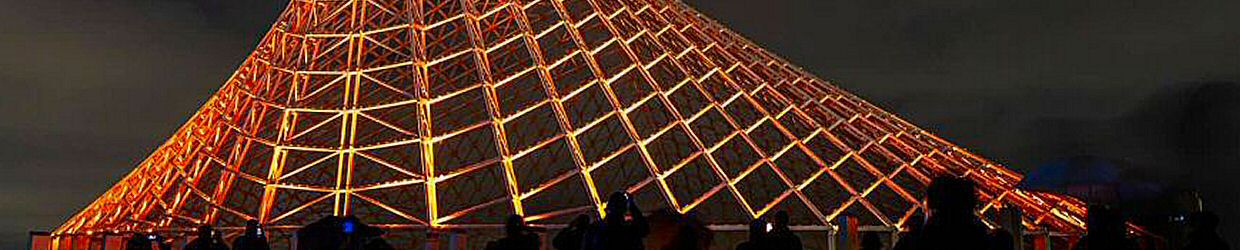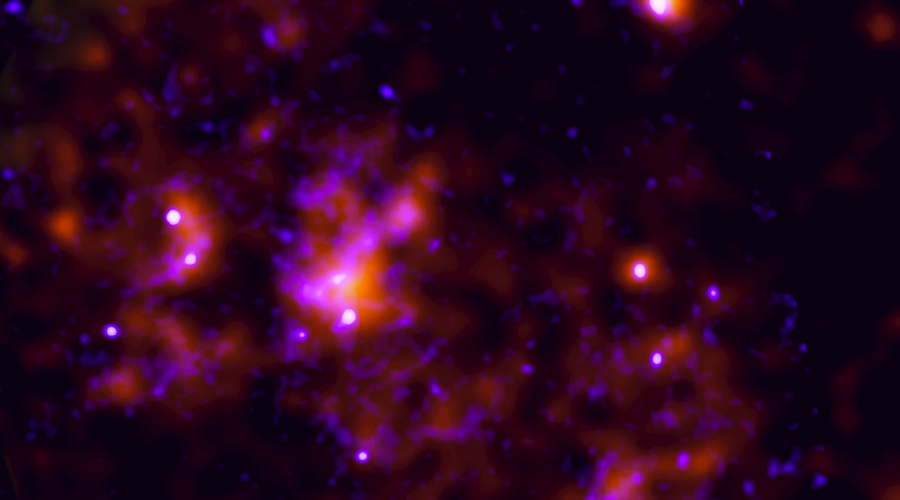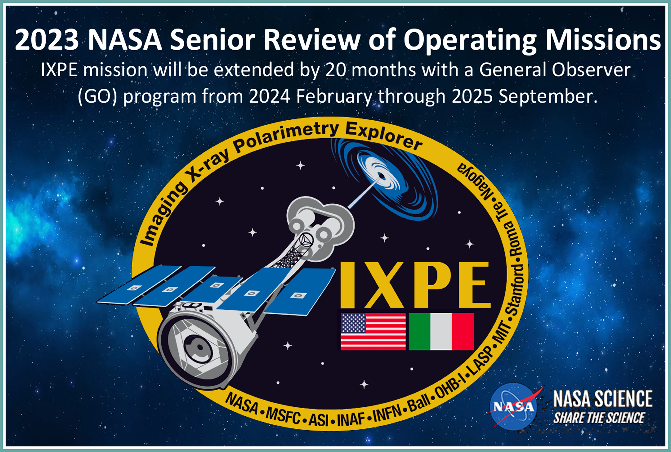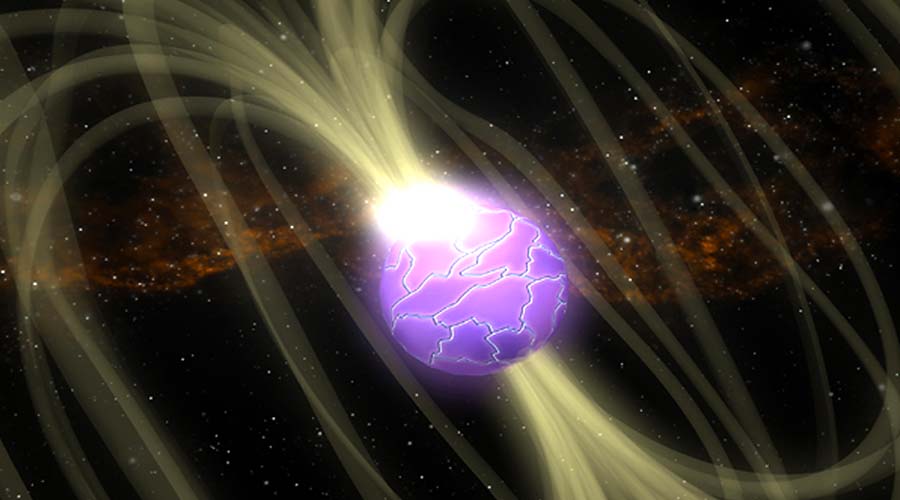L’esperimento IceCube, il più grande telescopio di neutrini del mondo che da oltre dieci anni studia il cosmo dalle profondità dei ghiacci dell’Antartide, ha realizzato una nuova e inaspettata osservazione: un’emissione diffusa di neutrini di energie molto elevate, da 500 GeV fino a diversi PeV, concentrata lungo la Via Lattea. La scoperta, che apre una nuova finestra sull’astrofisica delle alte energie nella nostra galassia, è stata possibile anche grazie all’impiego di nuovi modelli teorici di emissione dei neutrini per l’interpretazione dei dati sperimentali: senza di essi, infatti, non sarebbe stato possibile identificare il tenue bagliore di neutrini della nostra galassia. Uno dei modelli teorici utilizzato, chiamato KRA_gamma, è stato sviluppato da un gruppo di ricercatori italiani dell’INFN e delle Università di Pisa, Federico II di Napoli, Sapienza di Roma, in collaborazione con colleghi del GSSI Gran Sasso Science Institute e dell’Università di Stoccolma. I risultati di IceCube sono stati pubblicati oggi, 29 giugno, su Science.
IceCube è stato il primo esperimento a rivelare, nel 2013, neutrini astrofisici di altissima energia, inaugurando la cosiddetta astronomia dei neutrini, che oggi consta di cataloghi con centinaia di eventi.
Nel 2018, IceCube ha annunciato l’identificazione di una loro prima sorgente extra galattica, ma ad oggi l’origine della maggior parte dei neutrini rivelati rimane non identificata. Comunque, la distribuzione fortemente isotropa di questi eventi sulla sfera celeste lascia ritenere che essi siano prevalentemente di origine extra galattica.
Tuttavia, anche la Via Lattea deve essere una sorgente di neutrini di altissima energia, perché sappiamo che vengono prodotti nelle collisioni della componente adronica (protoni e nuclei leggeri) dominante nei raggi cosmici diffusi in tutta la galassia con il gas interstellare. E la nuova scoperta di IceCube conferma proprio l’esistenza di una emissione diffusa di natura adronica dalla Via Lattea, che si estende, però, inaspettatamente, fino a energie oltre il PeV, con un flusso ben superiore a quello predetto dai modelli convenzionali di trasporto dei raggi cosmici e in accordo con il modello KRA_gamma. Se i primi fossero stati corretti, IceCube non avrebbe avuto, ancora per diversi altri anni, statistica sufficiente per rivelare l’emissione galattica.
Il risultato che la Collaborazione Scientifica IceCube è riuscita a realizzare, grazie anche all’interpretazione dei dati sperimentali sulla base del nuovo modello teorico, è una conquista scientifica di notevole importanza, che sembra, quindi, riservarci già delle belle sorprese.
Peraltro, questa emissione di neutrini deve avere un corrispettivo nei raggi gamma (radiazione elettromagnetica di altissima energia), che alcuni esperimenti hanno effettivamente osservato, come riportato dai recentissimi risultati della collaborazione LHAASO. Tuttavia, i raggi gamma potrebbero anche essere prodotti da elettroni ultrarelativistici, ad esempio originati da pulsar, solo che, in questo caso, non darebbero luogo a neutrini. Il modello teorico KRA_gamma, utilizzato dalla Collaborazione IceCube, tenendo conto di alcune anomalie precedentemente riscontrate nei dati gamma e usando avanzati strumenti numerici, risulta in ottimo accordo sia con i dati di IceCube sui neutrini, sia con i dati di LHAASO sui raggi gamma.
Queste nuove osservazioni sembrano così implicare che la popolazione di raggi cosmici nelle regioni più interne del piano galattico è più energetica di quella osservata in prossimità della Terra da esperimenti come AMS sulla Stazione Spaziale Internazionale. E, oltre ad avere forti implicazioni per la fisica del trasporto dei raggi cosmici, questo risultato è importante anche perché può aiutarci nel prossimo futuro a comprendere la loro, ancora misteriosa, origine.
La tanto attesa scoperta delle interazioni di raggi cosmici nella nostra galassia è un grande progresso nella comprensione dei misteri attorno alle sorgenti di raggi cosmici. Ulteriori preziose conferme e dettagli necessari a completare questi nuovi scenari verranno delle future analisi dei dati di IceCube e dai risultati degli osservatori per raggi gamma e telescopi per neutrini di prossima generazione, come KM3NeT, IceCube Gen 2 e Baikal-GVD. In particolare, KM3NeT, un telescopio simile in dimensioni ad IceCube, è in fase di realizzazione da parte di altro gruppo internazionale di scienziati nel Mare Mediterraneo. Pensato per operare dalle profondità marine in due siti distinti, tra cui la Sicilia, KM3NeT è supportato dallo European Strategy Forum of Research Infrastructures (ESFRI), e inserito nel Piano Nazionale delle Infrastrutture di Ricerca (PNIR) del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), e riconosciuto come infrastruttura di ricerca di interesse strategico dalla Regione Siciliana. KM3NeT sarà uno degli esperimenti di punta dell’INFN per i prossimi anni e avrà il piano galattico come principale obbiettivo di osservazione. Anche la collaborazione europea ANTARES, alla quale l’INFN partecipa sin dalle fasi iniziali, sta cercando un eccesso astrofisico di neutrini che segua la distribuzione spaziale ed energetica prevista da questo ultimo aggiornamento del modello KRA_gamma, avendo a disposizione un catalogo ampio di dati, e ha recentemente individuato un possibile eccesso dalle regioni centrali della nostra galassia.
ll telescopio di neutrini IceCube è stato costruito ed è operato dalla National Science Foundation (NSF) con il supporto finanziario e la partecipazione di varie istituzioni membri della Collaborazione IceCube provenienti da quattordici paesi, tra cui l’Università degli Studi di Padova, solo gruppo italiano che partecipa al progetto, il cui contributo è coordinato da Elisa Bernardini del Dipartimento di Fisica e Astronomia.
I modelli impiegati per l’interpretazione dei dati sperimentali dalla collaborazione IceCube e che hanno contribuito all’importante scoperta sono stati elaborati da Daniele Gaggero e Dario Grasso della Sezione INFN di Pisa e dell’Università di Pisa, Antonio Marinelli dell’Università Federico II e della Sezione INFN di Napoli, Alfredo Urbano e Mauro Valli della Sapienza e della Sezione INFN di Roma, in collaborazione con Carmelo Evoli del GSSI e dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN e Pedro de La Torre Luque dell’Università di Stoccolma. In particolare, il modello modello KRA_gamma^5 è stato presentato in Astrophys.J.Lett. 815 (2015) 2, L25 • e-Print: 1504.00227 [astro-ph.HE], e recentemente aggiornato sulla base di nuovi dati in Front.Astron.Space Sci. 9 (2022) 1041838 • e-Print: 2209.10011 [astro-ph.HE].